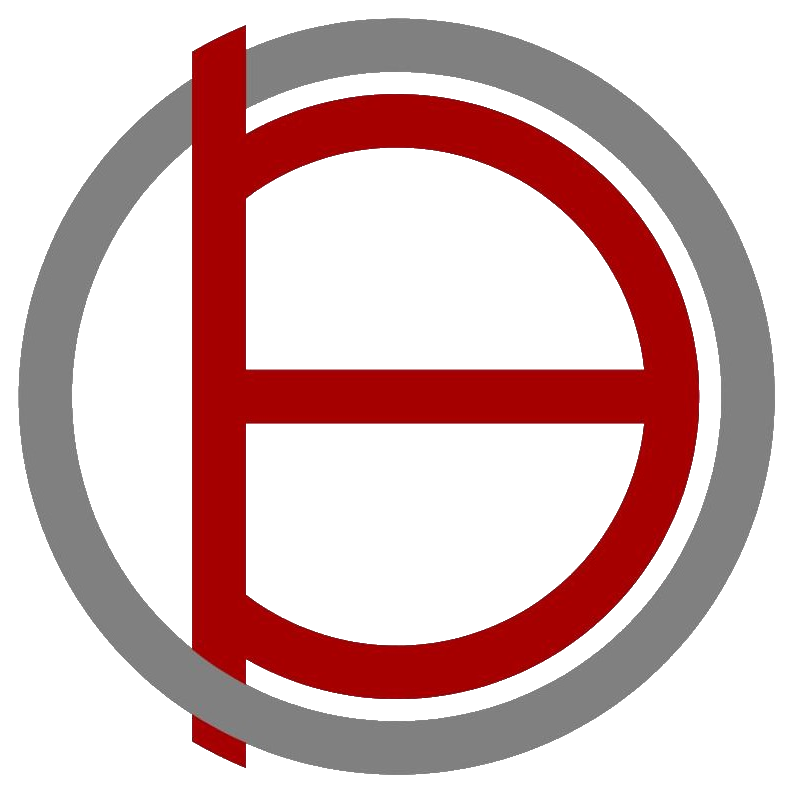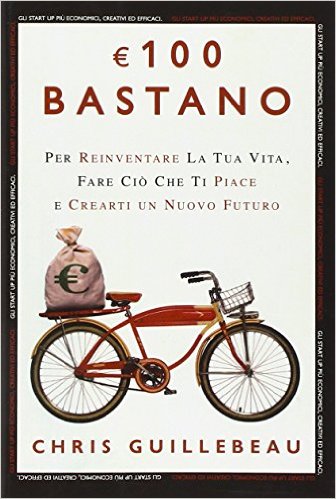Ti è mai capitato di tornare a casa tardi, andare a dormire all’1.00 di notte e svegliarti alle 5.30 con una sensazione addosso di fretta?
E di non riuscire più a prendere sonno e di arrenderti e alzarti alle 7.00?
Stamattina per me è stata così.
(E la cosa che mi consola è che – essendo sabato – magari oggi pomeriggio ci scappa un pisolo con un po’ di recupero.)
Ma quando succede una cosa così?
Quando hai una preoccupazione.
Quando hai un problema da risolvere e non ti dai pace fino a che non lo hai risolto.
Quando qualcosa “bolle in pentola nel retrocranio” e – forse – spinge per emergere e spinge per farti fare…
Non so se in chi legge c’è qualcuno che si trova in una situazione di questo tipo: le soddisfazioni lavorative sono in caduta libera in avvitamento verso il basso (ed i colleghi attorno a te li vedi stanchi, se non come te, più di te); vorresti fare altro ma non trovi il tempo se non rosicchiando angoli di riflessione durante i tragitti da e per l’ufficio e rubando ore di sonno; vorresti fare altro ma non riesci a focalizzarti su come gestire la situazione da un punto di vista finanziario…
Insomma un turbine di cose che si agitano nella testa e premono per configurarsi in una qualche struttura logica a te sconosciuta.
E questa struttura logica combatte contro uno dei tuoi più grossi demoni: la paura.
Quella paura di non farcela professionalmente ed economicamente.
Ma ti rendi conto anche che la paura ha una piccola falla che potrebbe essere la tua salvezza, la tua spinta definitiva verso un salto (non privo di rischi) che deve però escludere una programmazione ed una visione oltre l’anno (se non raccontando una storia che può “stimolarti a”).
La falla che potrebbe essere la tua salvezza si chiama “fuga”.
Fuga da situazioni di riconoscimento professionale sconfortanti.
Fuga da luoghi virtuali nei quali la tua professionalità non conta nulla: conta solo un mostro che assume diverse forme e nomi (burocrazia, profitto,… chiamalo come ti pare, perché tanto ha diverse facce…).
E allora pensi.
Ti rigiri nel letto in ansia.
Hai fretta.
Hai paura di perdere questa strana pressione di spinta all’azione, che però necessita di un finale colpo di reni che ti faccia tirare giù con una precisa spallata (neanche tanto forte) l’ultimo diaframma che ti separa dallo spazio che sta dall’altra parte e che si chiama “tentativo” (se mai provi, mai sai…).
“Tentativo” che però si deve confrontare con un altro spettro: quello del “e se poi non ce la fai?”
Quello spettro che rappresenta l’ultimo legaccio strategico che ti potrebbe tenere inchiodato qui.
Nello status-quo di qualcosa che sai benissimo che non ti rappresenta più e che – se non affrontato – ti condanna a vivere qualcosa di non tuo.
Ed in questo turbine di pensieri mattutini, ripensi a frasi dette da persone che stimi, spunti che ti sono stati offerti, caratteristiche che sono state individuate da altri (ognuno ne ha vista una, ma se ci pensi un comune denominatore c’è, anche se la tua logica e la tua razionalità stentano a capire… e questo rappresenta un ulteriore problema da affrontare).
Ripensi ai mesi di questo anno che si sta avviando alla fine e che ti ha spremuto come un limone. Ma che ti ha insegnato tanto.
Rifletti su storie di persone che conosci, che hanno avuto il coraggio di buttarsi (con tutta l’ansia del pianeta a fargli da fardello) e che adesso stanno arrivando. Ce la stanno facendo, tutti: nessuno è tornato sui propri passi.
Pensi che forse ce la puoi fare anche tu.
Solo che non hai mai avuto il coraggio di tentare.
Pensi che devi solo prenderti il tempo (senza scuse) per pianificare bene la cosa (così metti in pace la tua coscienza, che ti dà del folle sconsigliandoti vivamente di fare cose insensate “perché non è il momento adatto, e poi hai già una certa età”…).
E hai bisogno di tempo e di spazio, per sgombrare e per fare posto a cose nuove.
È possibile che da una serata trascorsa a fare quattro chiacchiere con una amica davanti ad una pizza ti emergano nottetempo queste riflessioni?
Pare di sì.
(Serata dove, tra le altre cose, raccontandole entusiasta del tuo telefono Android, i signori del tavolo a fianco ti chiedono timidamente informazioni sul telefono e tu – parlandogliene – glielo vendi [!!!]… eggià… la vendita, il tuo peggiore demone…)
Forse è stata la ciliegina sulla torta (o una delle ciliegine sulla torta) di un lungo processo decisionale, molto più complesso del peggiore consiglio di amministrazione mai visto sino ad oggi…
Se la decisione è presa, devi solo pianificare sul serio.
E smettere di rigirarti su te stesso, trovando scusanti varie ed eventuali che fanno scorrere inesorabilmente il tempo, che non si riavvolge più…
Immagine tratta da http://www.giornalettismo.it]