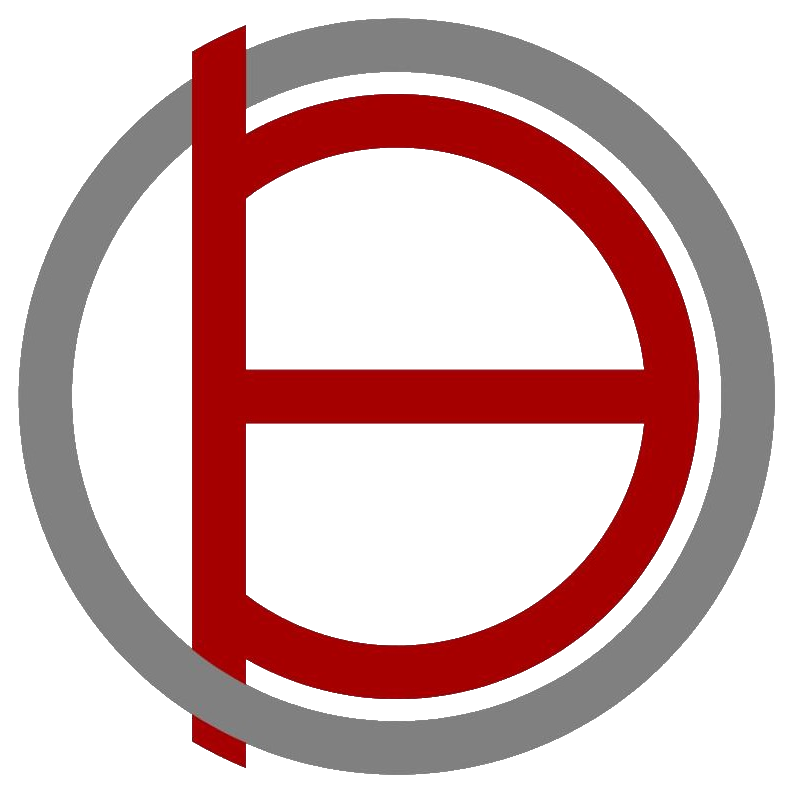Non so se vi è mai capitato di prestare attenzione alle parole che dite, che pensate e che usate durante le conversazioni.
So che sembra una considerazione stravagante, ma è una mia personale fissa che inseguo e perseguo da diverso tempo.
Questa mia “sensibilità” (chiamiamola così) deriva da dei corsi che ho fatto in passato, nei quali mi hanno insegnato ad essere un po’ più consapevole del linguaggio usato sia verso l’esterno (raccontando e interloquendo con qualcuno), sia verso l’interno (raccontandosela).
Imparando che le parole che diciamo – e ci diciamo – disegnano la nostra realtà e quello che gli altri percepiscono di noi.
E nel corso di questi anni ho avuto modo di osservarlo anche in altre persone, ascoltando con attenzione quello che dicono.
Riconoscendo alcune parole chiave che vengono utilizzate e osservando del loro effetto in chi ascolta.
Accorgendomi di termini ricorrenti utilizzati che – in accezioni negative – diventano dei veri e propri bachi nella percezione della realtà.

E recentemente – nei tanti colloqui avuti coi medici – mi sono accorta ancora di più di quanta importanza stessi dando al linguaggio usato.
Da me e dagli altri.
Per esempio mi sono resa conto che alcuni verbi tendevo a coniugarli al presente a scongiurare (metaforicamente parlando) e a rifuggire l’ipotesi di scenari negativi.
In una situazione specifica, dovendo fare una domanda che poteva urtare la sfera professionale dei medici (che stavano facendo l’impossibile) – e non riuscendo a calibrare la persona che avevo davanti (che in altre occasioni, devo avere involontariamente urtato inciampando in parole sensibili) – mi sono dovuta “attrezzare” con una premessa (“La prego di prendere la domanda che sto per farle con le dovute pinze, perché non sono in grado di trovare termini migliori di questi per fargliela…”).
Altre parole urtavano – inaspettatamente e pesantemente – il mio stato mentale e psichico: paradossalmente parole come “abbraccio”, “carezza”, “amore” non volevo sentirle pronunciare (ma non ho mai avuto il coraggio di dirlo, semplicemente quando accadeva smettevo di ascoltare).
“Come mai?”, si chiederà qualcuno.
Perché – per gestire il peso emotivo – mi sforzavo di spostare la lettura della realtà tutta dal lato scienza e battaglia (per la vita). Due interpretazioni che mi tornavano più utili per mantenere un po’ di energia e di lucidità.
La parola “morte” non l’ho mai pronunciata.
Neanche mentalmente.
Forse oggi – qui – mentre scrivo, è la prima volta che lo faccio.
Perché?
Perché – presumo – la ristrutturazione linguistica aveva raggiunto livelli estremi.
Ed il tentativo di governare lo stato di alterazione emotiva passava anche attraverso questa personale modalità (edulcorando più o meno la lettura della situazione, o rendendola il più possibile asettica).
E la reazione (solamente interiore) davanti al linguaggio usato dai medici (differente da medico a medico) poteva tenermi calma, mandarmi in bestia, darmi speranza oppure tenermi in uno stato di fredda neutralità (quasi di “galleggiamento”).
Pur dicendo tutti la stessa cosa.

Le parole usate hanno una importanza notevole. Si sa.
E quello che dici ha una ricaduta in chi ti ascolta. Inducendogli non solo la lettura della realtà, ma anche la lettura e l’opinione che si fa di te.
Credo quindi che la scelta delle parole da usare sia una operazione molto delicata.
Quasi etica in situazioni ad alta sensibilità.
Una scelta che necessita di una operazione preventiva di calibrazione dell’altro molto accurata.
Un lavoro che – nello specifico della mia personale esperienza – non può essere fatto solo dal personale medico (che ha ben altre comprensibili priorità), ma che potrebbe essere fatto da specifici “facilitatori” fortemente orientati all’ascolto e all’osservazione di chi ti siede davanti. Capaci di fare da mediatori (e traduttori) nel dialogo tra medici e parenti dei pazienti (ma anche pazienti).
[Immagini tratte da Pexels]