
Questo post si presterebbe ad una lunga riflessione sulla bontà della lettura non solo in termini ludici o informativi, ma anche in termini terapeutici.
E non mi sto riferendo solo alla Biblioterapia (una disciplina frutto della fusione – come dice il termine stesso – della terapia, nella accezione psicologica del termine, con la lettura di specifici libri suggeriti da specialisti), ma anche agli incontri “casuali” con testi che “ti capitano” e che si rivelano essere adatti a superare momenti complessi che ci si trova ad attraversare.
Ma cercherò di raccontare solo della mia recente lettura di due libri che mi hanno aperto un mondo (da un lato) e stanno facendo la differenza (dall’altro lato).
Il mio “incontro letterario” con Irvin D. Yalom risale a qualche anno fa.
In un momento in cui ero stufa di leggere manuali di crescita personale.
In un momento in cui cercavo stimoli per fare “quel passo in più”, ma non riuscivo a trovare nulla che mi coinvolgesse a sufficienza.
Ed un giorno, aggirandomi tra gli scaffali di una Feltrinelli, mi cadde l’occhio su “Il problema Spinoza”.
Incuriosita, lo presi e me lo rigirai tra le mani (la sensazione tattile dei libri di carta, in particolare quelli con la copertina morbida, che sembrano ancora più malleabili… adattabili a te e alla tua mano).
Lessi la trama e la curiosità aumentò.
Decisi così di acquistarlo, iniziai quasi subito a leggerlo e fu una epifania.

In breve venni coinvolta ed assorbita dalla storia.
Diventò uno di quei libri per i quali non vedi l’ora di trovare briciole di tempo per poterli leggere.
Ma c’è di più: mi resi conto che le parole mi emozionavano e – talvolta – mi disturbavano in modo inconsueto.
E solo allora andai a leggere le righe che raccontavano dell’autore, scoprendo che si trattava di uno psichiatra.
Il mio primo pensiero fu: “Ecco perché!”
“Ecco perché le sue parole mi coinvolgono così tanto!”, pensai.
Il suo modo di narrare era diverso.
Era qualcosa di sottile che si insinuava e lavorava in background in me che leggevo.
Avevo scoperto un nuovo autore (nuovo per me, perché parlando con amici mi resi conto che era ben noto e – anzi – ricevetti suggerimenti di altri suoi titoli).
Ma soprattutto avevo scoperto una nuova narrativa.
Passò il tempo, lessi altri libri.
Di recente rincontro Yalom.
Non ricordo se e come sono stata “catturata” da “Diventare se stessi”.
Forse – molto semplicemente – ho visto il suo nuovo libro e l’ho comprato a scatola chiusa, forte dell’esperienza positiva, scoprendo solo dopo che era adatto per questo momento. Leggendo un’autobiografia ricca di spunti di riflessione.
Una storia di una vita piena (e non priva di difficoltà), pregna di conoscenza e che invita alla riflessione. Narrando.
Già, la narrazione.
Uno strumento potente per trasmettere conoscenza e sapere.
Capace di arrivare dritto al cuore e alla mente di chi ascolta.
E – nel mio caso – uno strumento importante per affrontare un momento complesso, di transizione.
Di grande aiuto alla comprensione della serena inevitabilità che trasmette.
Ma gli incontri (ed i secondi incontri) non finiscono qui.

“L’uomo che scambiò sua moglie per un cappello” di Oliver Sacks è l’altro libro che ho incontrato in questa fase della vita.
Qui si è trattato anche di una rappacificazione con l’autore perché il primo approccio con Sacks fu piuttosto “complesso”: “Zio Tungsteno” mi fu caldamente consigliato diversi anni fa da Giorgio Antonelli (autore del bellissimo – e temo ormai introvabile – libro “La ballata della luce”), che intervistai per la rivista “Casa 99idee”.
Accettai con entusiasmo il consiglio ma la lettura fu assai difficoltosa: un trattato di Chimica in forma narrativa, con tanto di tavola periodica e complesse dissertazioni.
E vista la mia “allergia” alla materia (al liceo presi anche un 3 durante un compito in classe), terminai faticosamente la lettura, giurando a me stessa: “Mai più!”.
Invece – a distanza di anni – mi sono ritrovata a leggere con grande attenzione e commozione il libro di cui avevo sempre sentito parlare un gran bene, ma che per esperienza pregressa non osavo avvicinare (a differenza di Yalom).
E se con Yalom ho assaporato (e continuerò ad assaporare, leggendo altri suoi testi) la contaminazione di generi, lasciandomi trasportare da storie che trasmettono anche contenuti psicologici generatori di riflessioni, con Sacks ho scoperto cosa è la “medicina narrativa”.
La delicatezza ed il sentimento espresso nella narrazione dei “casi clinici”, che sono visti, raccontati e considerati soprattutto come persone con una loro storia, mi ha avvolto e trasportato lungo le pagine del libro.
Generando empatia verso questi protagonisti sfortunati.
Due libri capitati al momento giusto, capaci di confortare, informare, far comprendere e far riflettere.
Capaci di aprirmi a nuovi ambiti di conoscenza, aiutandomi ad attraversare una fase complessa con il giusto e delicato equilibrio tra scienza, emozioni e narrazione.
Ecco, forse è proprio questo che io considero lettura terapeutica: tu (e le tue emozioni) con il libro giusto in grado di accompagnarti e sostenerti.
Chiudo questo post con una “nuova abitudine” che vorrei mantenere.
Due tracce audio caricate sul mio profilo Spreaker inaugurato da poco, relative alla lettura dei due incipit dei libri qui raccontati:
L’uomo che scambiò sua moglie per un cappello
Buon ascolto. E buona lettura.
[Nelle foto in basso: da sinistra a destra, Irvin D. Yalom (©BrainPickings) e Oliver Sacks (©Pinterest)]
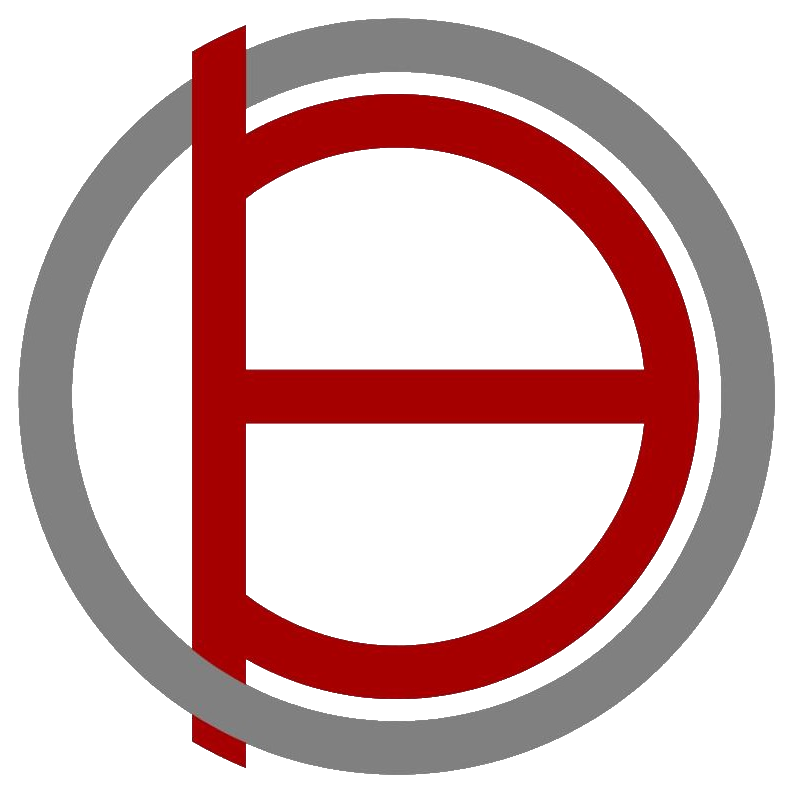








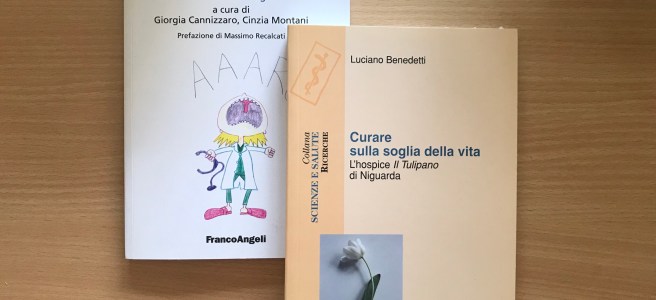




 Una delle affermazioni che mi sono rimaste impresse durante i tanti colloqui (che erano quasi dei dialoghi) avuti con i medici del reparto è stata questa:
Una delle affermazioni che mi sono rimaste impresse durante i tanti colloqui (che erano quasi dei dialoghi) avuti con i medici del reparto è stata questa: Devi accettare una suddivisione di compiti e – se il reparto ed il personale te lo consente (e noi abbiamo avuto questa possibilità) – lasciare che chi è del mestiere maneggi la materia e si occupi dell’aspetto tecnico e di cura, accettando dal canto tuo la delega che ti viene data di occuparti dell’aspetto empatico ed emotivo di chi giace nel letto (anche se in stato di sedazione).
Devi accettare una suddivisione di compiti e – se il reparto ed il personale te lo consente (e noi abbiamo avuto questa possibilità) – lasciare che chi è del mestiere maneggi la materia e si occupi dell’aspetto tecnico e di cura, accettando dal canto tuo la delega che ti viene data di occuparti dell’aspetto empatico ed emotivo di chi giace nel letto (anche se in stato di sedazione).






 Ebbene, ho imparato cosa sono la calma e la pazienza.
Ebbene, ho imparato cosa sono la calma e la pazienza. Ho imparato cos’è la costanza (e la sua associata: la tenacia).
Ho imparato cos’è la costanza (e la sua associata: la tenacia). Ed infine ho imparato cos’è la resilienza.
Ed infine ho imparato cos’è la resilienza.



