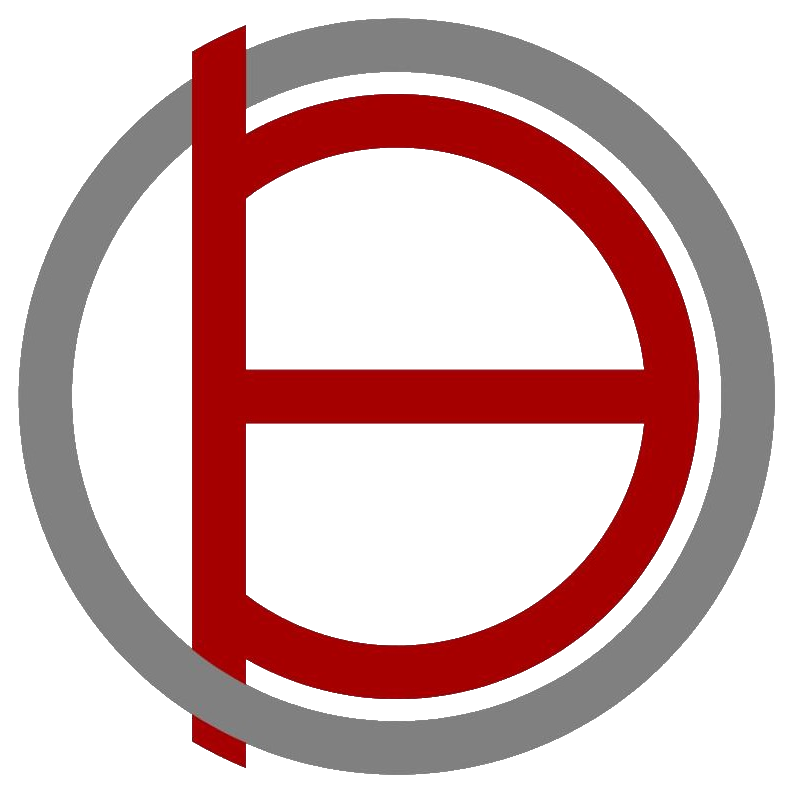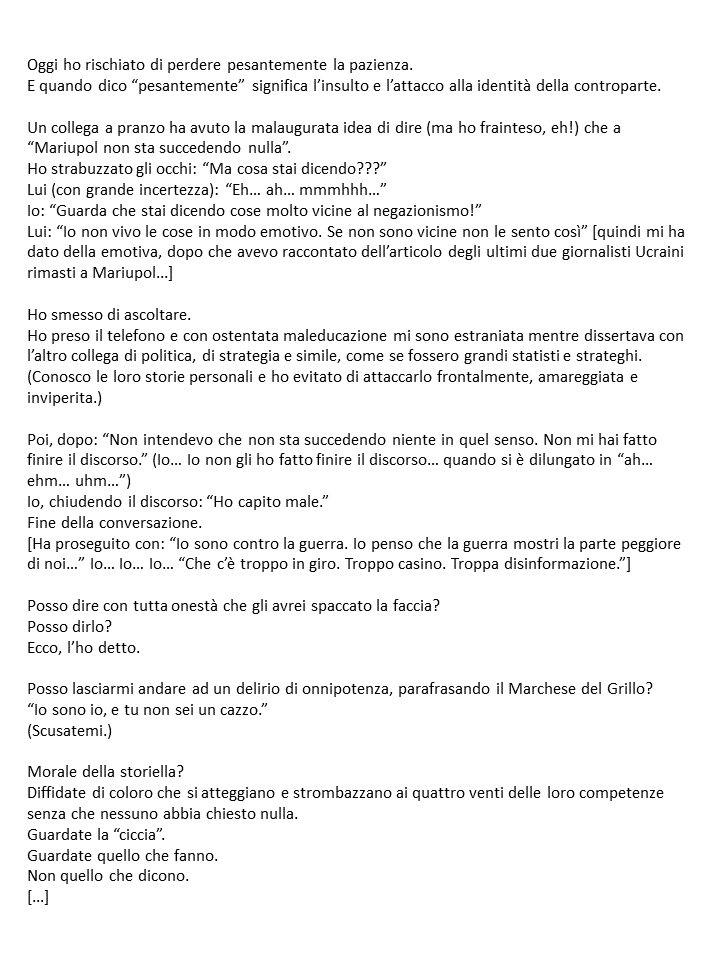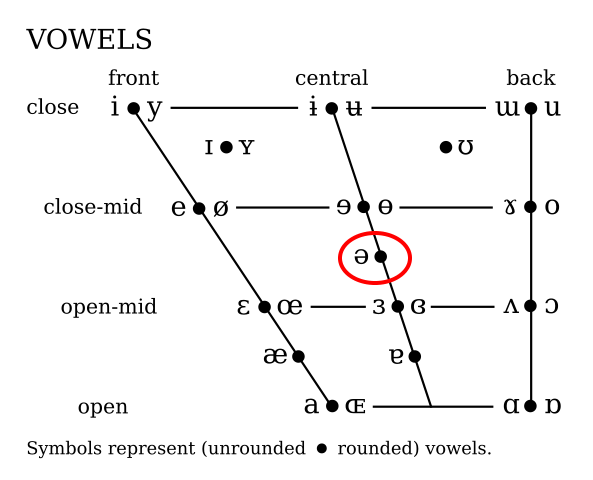Da tempo ragiono sul se e come narrare quello che si fa (e/o si è) sui social media.
Sto diventando tediosa sul tema, me ne rendo conto.
E all’interno di questo ragionamento si muovono tante variabili anche apparentemente slegate fra loro: ci sono i selfie scattati (vedo profili – soprattutto su Instagram – quasi completamente composti di selfie), ci sono le foto dei cibi mangiati, dei libri letti, dei luoghi visitati…
Alcuni temi mi sono più confortevoli (libri, luoghi e forse anche qualcosa di cibo…), altri mi creano decisamente disagio (i selfie… ma il mio rapporto con l’obiettivo fotografico è sempre stato complesso e riassumibile in “sì a fotografare, no a farsi fotografare”).
E ragionando (ancora) sul tema – questa mattina – mi sono venute in mente due cose lette su due libri lontanissimi tra loro.
La prima è una citazione tratta dall’ultimo libro di Guia Soncini “Questi sono i 50. La fine dell’età adulta.”:
“Una volta decidevi se iscriverti a Legge o a Medicina, oggi puoi decidere che a quarant’anni ti guadagnerai da vivere raccontando com’era il mondo quando ne avevi dodici. Ma dev’essere personale, mica roba da libri di storia. Devi saper narrare le merendine, e i cartoni animati, e non le ragioni della guerra in Afghanistan ma dov’eri quando vedesti per la prima volta le immagini delle torri che crollavano. Non fatturerai con la guerra santa in sé, ma col dettaglio di te che avevi comprato il regalo per il tuo compagno di banco ma la guerra santa fece annullare la festa: quanta vendibilissima immedesimabilità nelle piccole cose, altro che geopolitica, altro che la storia maiuscola. Devi fare cascina di futilità: un giorno tutto questo sarà reddito.
Domenico Starnone, che appartiene al secolo in cui per guadagnarti da vivere con la nostalgia dovevi saper scrivere, mica solo avere un telefono con la telecamera, dice che la letteratura si fa su una bottiglietta di chinotto: «Non sulla bottiglia in sé, ma sull’impatto tra me e la bottiglia, l’urto tra me e la parola chinotto, l’emozione che mi dà».”
La seconda è un ricordo che arriva da un libro che – nonostante il titolo che può ingannare (“Miliardario a cinque stelle” di Tash Aw) – offre un amaro spaccato della società asiatica.
Ambientato a Shanghai, narra le vicende di quattro persone socialmente lontanissime tra loro, le cui vite si intrecciano e si incrociano in modo inaspettato (un cantante pop, un imprenditrice, un imprenditore ed una ragazza in cerca di fortuna).
La ragazza in cerca di fortuna, arrivata a Shanghai, inizia a costruire la sua immagine e la sua reputazione comprando imitazioni di capi e accessori di marca, leggendo libri di autoaiuto su “come fare per…” e postando sui social media la propria vita progettata a tavolino.
Tra i tanti dettagli della narrazione di questa figura, una mi aveva colpito in particolare (e mi è tornata in mente proprio questa mattina): quando decide di aprire il primo profilo social e sceglie una foto che le è stata scattata da un passante durante una visita in un giardino,
“Guardando quella foto sullo schermo del computer capì che era esattamente la più adatta da mettere sul profilo: scattata da qualcun altro, un’amica durante una gita, magari addirittura da un fidanzato. Le dava un’aria desiderabile, diversamente dai tipici autoscatti confusi dove i soggetti avevano sempre lo sguardo all’insù verso l’obiettivo, comunicando istantaneamente all’osservatore: non ho amici.“
A parte la “questione selfie” (laterale ma non per questo trascurabile, su cui andrebbero spese ulteriori parole), riflettevo che la narrazione della propria vita genera in chi ci legge non solo un posizionamento reputazionale e caratteriale (e anche delle contro-riflessioni), ma suggerisce anche possibili scenari professionali alternativi che possono essere invisibili a noi narratorә (immersә come siamo nel flusso della nostra storia e della nostra cronaca) e che sono costituiti del contenuto che pubblichiamo, supportato a sua volta dalla nostra esperienza (più o meno sistematizzata, più o meno consapevolmente).
Quindi, torno a domandarmi, ha senso narrarsi sui social?
Ha senso condividere ciò che si fa, si legge, si visita, si pensa…?
Sì. A questo punto credo di sì.
[Aggiungo: ha senso condividere costantemente il nostro volto? Dipende, da quello che vuoi comunicare. Perché tutte e tutti desideriamo comunicare qualcosa a qualcuno.]
E di una cosa sono certa: non esiste un unico modo per narrarsi, ne esistono tanti (anche non narrarsi è un modo per narrarsi). Altrimenti non sarebbe auto-narrazione.
L’importante è esserne consapevoli.
Avendo sempre in mente il mantra “ciò che pubblichi ti posiziona”, senza dimenticare che ad una azione corrisponde sempre una reazione.
[Foto di Madrona Rose su Unsplash]