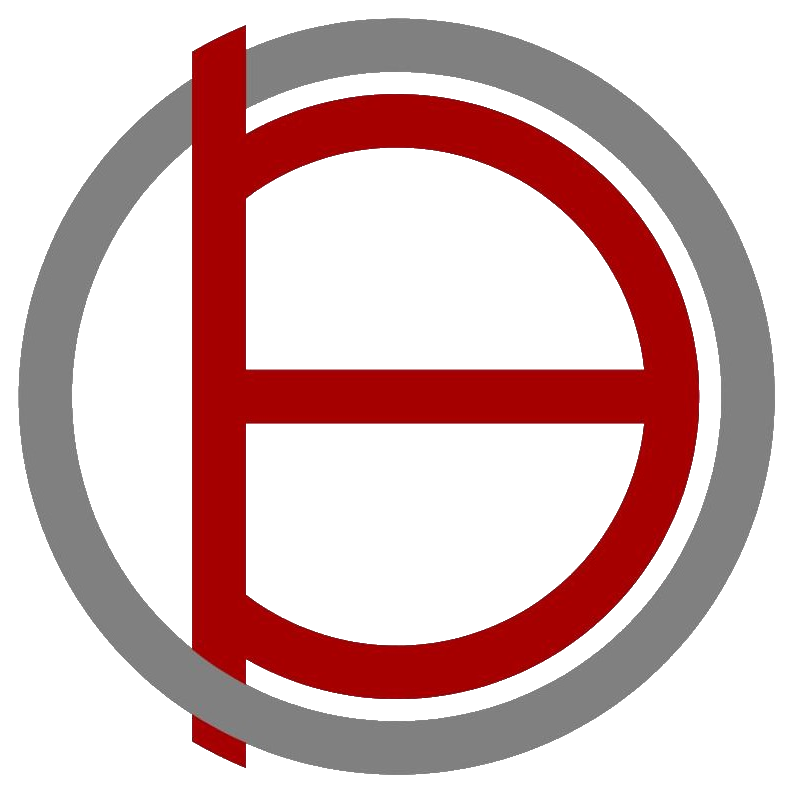Il caso ha voluto che oggi (11 agosto) mi sia ritrovata a scrivere poco fa un post di omaggio su Michela Murgia (morta ieri, 10 agosto).
Scrivo “il caso” perché oggi è un anno che è morta una cara amica di infanzia, che conoscevo da più di quarant’anni (quasi cinquanta).
Oggi (verso le due del pomeriggio) ricevevo la telefonata che comunque sapevo che sarebbe arrivata.
Non voglio sembrare disumana, ma quando ascoltai le parole di Silvia (la prima con cui parlai) sentii un senso di liberazione.
Come un grande respiro a pieni polmoni, dopo tanto tempo di insufficienza respiratoria. Di costrizione.
Pensai: “Signore ti ringrazio. È finita.”
C’era il dolore gigantesco che la morte porta con sé, ma c’era anche quella sensazione che viene ben descritta dalla frase “che la terra ti sia lieve”.
Perché – per me – vedere la distruzione che quel male stava operando sulla persona Stefania e la sua dignità di essere umano, era insopportabile. Un senso di impotenza inaudito.
Di quelle prime ore ricordo la disperazione di Evelin, la compostezza dolorosa di Ilaria (“Se succede, per favore, chiamami. Non mandarmi un messaggio.”, e così feci), la voce sotto shock (quasi “instupidita”) della figlia quando la chiamai a distanza di qualche ora, e poi via via i messaggi audio e scritti della rete di amici.
Ricordo il personale “terrore” di dovermi avvicinare ad una madre che aveva perso la figlia (“non ce la faccio”, mi ripetevo spesso nelle ore trascorse tra la notizia e il viaggio verso Milano; poi sono andata e l’ho fatto, mi sono seduta in cucina con lei e la zia e siamo state lì, in silenzio, solo qualche parola; cosa puoi dire ad una madre che sta seppellendo la propria figlia?).
Ci sono frammenti di alcune immagini e alcuni ricordi di quei tre mesi di un anno fa che mi porto ancora dentro e che so che il tempo aiuterà a mitigare e a ristrutturare (come si dice in questi casi). Di cui non ho scritto e ho detto a pochi.
E di questo dirne a pochi, o conservare dentro di sé, mi ha fatto riflettere un libro che sto leggendo (“La società della performance” di Maura Gancitano e Andrea Colamedici) nel quale viene scritto dei sentimenti condivisi: alcuni sentimenti, nel momento in cui vengono condivisi, perdono l’essenza (l’anima, si potrebbe dire); alcuni sentimenti non sono condivisibili proprio per la loro natura.
Con questo non sto dicendo che chi condivide sentimenti e vicende personali li snatura. Assolutamente no; sono la prima a farlo.
Sono convinta che come esseri umani abbiamo bisogno di condividere con i nostri simili, e abbiamo bisogno di scrivere da qualche parte i nostri ricordi (la scrittura come atto terapeutico e/o di consapevolezza e/o di messa a fuoco, come scrive Nicoletta Cinotti nel suo “Scrivere la mente” [tra i consigli di lettura di Mafe De Baggis]; così come ricordo sempre quello che lessi nel libro di Roberto Cotroneo “Il sogno di scrivere” che paragonava il nostro pubblicare sui social media come la scrittura del più grande romanzo collettivo).
Il cosa scrivere, il cosa condividere, è un atto estremamente personale.
Perché ricordo che al primo anniversario di morte di mia madre (morta il 28 marzo 2018) io non scrissi nulla.
Volevo dimenticare? Può darsi.
Ma forse stavo solo interiorizzando. Metabolizzando.
E avevo bisogno di un po’ di silenzio esterno ed anche interno.
Un anno fa, comunque, se ne andava una carissima amica. E forse – oggi – a distanza di un anno, ne sento ancora di più la mancanza.
Come a distanza di mesi dalla morte di mia mamma quando alla sera – prima di addormentarmi – come una personale preghiera dicevo: “Ti voglio bene mamma. Ovunque tu sia.” (e mi addormentavo abbracciata al cuscino).
[La foto è di Quaritsch Photography su Pexel]